A commento della recente Giornata mondiale del rifugiato (20 giugno),Maurizio Ambrosini, docente di Sociologia delle migrazioni all’Università di Milano, ha preparato questa lettura del rapporto annuale dell’UNHCR.
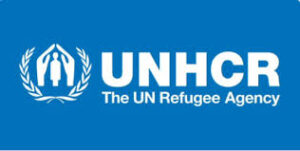 In prossimità del 20 giugno, l’UNHCR (l’Alto Commissariato ONU per i profughi) ha pubblicato il suo rapporto annuale e da lì ricaviamo le cifre che danno le dimensioni del fenomeno e forse sfatano qualche luogo comune. Un primo dato riguarda il volume del dramma dei profughi: una stima di 108,4 milioni di persone in fuga a fine 2022, con un aumento di 19,1 milioni rispetto al 2021: una crescita senza precedenti. Per di più, a questa umanità dolente altri si sono aggiunti nel 2023, soprattutto a causa del nuovo conflitto esploso in Sudan, portando la stima a 110 milioni.
In prossimità del 20 giugno, l’UNHCR (l’Alto Commissariato ONU per i profughi) ha pubblicato il suo rapporto annuale e da lì ricaviamo le cifre che danno le dimensioni del fenomeno e forse sfatano qualche luogo comune. Un primo dato riguarda il volume del dramma dei profughi: una stima di 108,4 milioni di persone in fuga a fine 2022, con un aumento di 19,1 milioni rispetto al 2021: una crescita senza precedenti. Per di più, a questa umanità dolente altri si sono aggiunti nel 2023, soprattutto a causa del nuovo conflitto esploso in Sudan, portando la stima a 110 milioni.
Come negli anni scorsi, tuttavia, la maggioranza dei profughi sono sfollati interni, ossia si spostano in un’altra regione del proprio paese che reputano un po’ più sicura: il 58%, vale a dire 62,5 milioni di persone. Le persone in fuga non si sono preparate a partire e in genere dispongono di pochi mezzi. Spesso non sono in grado di fare molta strada, e non di rado neppure lo desiderano: sperano piuttosto di poter rientrare presto alle loro case.
Ma il dato che più colpisce, e che le opinioni pubbliche occidentali tendono a ignorare, si riferisce al fatto che la grande maggioranza dei rifugiati, esattamente il 76%, sono accolti in paesi a basso e medio reddito. Vale anche in questo caso la regola della prossimità: il 70% dei rifugiati internazionali si ferma nei paesi confinanti. I 46 paesi meno sviluppati rappresentano meno dell’1,3% del prodotto interno lordo globale, eppure ospitano più del 20% di tutti i rifugiati. La Turchia rimane al vertice della classifica per valori assoluti, con 3,7 milioni di rifugiati, seguita dall’Iran con 3,4 (aumentati di molto a seguito della vittoria dei talebani in Afghanistan), dalla Colombia con 2,5 milioni (quasi tutti venezuelani), dalla Germania con 2,1 milioni, unico paese europeo tra i primi in graduatoria, dal Pakistan con 1,7 milioni, anch’esso coinvolto dalla crisi afghana. In rapporto alla popolazione, spicca ancora una volta il caso del martoriato Libano, con un rifugiato ogni 7 abitanti, mentre il Montenegro è salito al livello di 1 ogni 19.
Un altro dato in controtendenza rispetto alle percezioni diffuse e al discorso pubblico riguarda la posizione dell’Italia nella mappa mondiale ed europea dell’accoglienza: il nostro paese a fine 2022 accoglieva 354.414 persone, tra richiedenti asilo e rifugiati, di cui il 41% proveniva dall’Ucraina. Si tratta di poco più del 5% del totale degli immigrati in Italia (circa 6 milioni, compresi gli irregolari) e di una modesta percentuale rispetto ai profughi accolti nell’UE. Va ricordato che nel 2022 l’Italia ha ricevuto 77.200 richieste di asilo, contro le oltre 200.000 della Germania, le 137.500 della Francia, le 116.100 della Spagna.
Accoglienti verso i profughi ucraini (oltre 150.000), siamo invece convinti che coloro che arrivano via mare dal Sud del mondo (poco più di 100.000 nel 2022) rappresentino una minaccia esiziale per il nostro paese.
È un inquietante doppiopesismo della mente e del cuore.
Maurizio Ambrosini
Docente di Sociologia delle migrazioni all’Università di Milano






